di Luca Biscontini
Viene da sorridere pensando che Roma all’interno della celeberrima filmografia del regista riminese viene considerato un’opera minore, interlocutoria, situata tra I clown del 1970 e il fortunato Amarcord (1973), premiato con l’Oscar per il miglior film straniero. A rivederlo a distanza di anni suscita un vivo entusiasmo e, contemporaneamente, una certa amarezza provocata dal confronto con il panorama cinematografico attuale italiano, in cui non appena si intravede qualcosa che superi di poco la mediocrità si giubila scompostamente e, probabilmente, senza motivo. Il film di Fellini è volutamente frammentario, diviso in blocchi quasi autonomi, con diverse linee di fughe che danno corpo a un meraviglioso sfondo su cui si staglia la figura di una città straordinaria e indolente, clericale e barbarica, accogliente e indifferente, nobile e stracciona, caotica e mistica, una suburra dal cui ventre sgorgano neri liquami che contaminano, insozzano, e l’odore dei secoli è nauseante come se provenisse da una fogna a cielo aperto. È questa dimensione perturbante che Fellini ha cercato, riuscendoci, di mettere a fuoco, un’attrazione/repulsione che invischia tutti coloro che si ritrovano nella città dei papi; si entra stranieri e si esce romani. È un rapporto materno quello che si instaura con Roma e vi si fluttua all’interno imbevuti del suo straripante liquido amniotico che nutre fino ad intossicare (a tal proposito è significativa la sequenza il cui il rammollito figlio della padrona di casa, in cui alloggerà il giovane Fellini, si rannicchia vicino alla madre assumendo una regressiva posizione fetale).
Diversi, dicevamo, sono i capitoli che compongono il film: si parte dall’infanzia a Rimini, che poi costituirà un ricco materiale per il successivo Amarcord, e si passa all’arrivo a Roma, in cui il timido Federico (Peter Gonzales Falcon), riservato e compito, si troverà a confrontarsi con la cialtroneria dei romani, sempre pronti a sussumere ogni tipologia umana che gli si pari davanti.
Si prosegue con le caotiche sequenze del raccordo anulare, l’anello d’asfalto che circonda la capitale, soffocandola, in cui il regista entra in scena dirigendo una nutrita troupe che, con un ingombrante dolly su un furgone, cerca di cogliere con la macchina da presa il disastro antropologico che la società dei consumi ha compiuto, rendendo la città un coacervo di strade su cui circolano milioni di veicoli. Fellini entra in campo anche successivamente, quando si presta a un’intervista di alcuni giovani studenti che gli chiedono delucidazioni sul film che sta realizzando, invitandolo a non restituire la solita immagine della città pacioccona e qualunquista: considerazioni che Fellini teneva bene presenti e che comunque non gli impedirono di mettere a fuoco la prospettiva a lui più congeniale (viene subito alla mente, in tal senso, la giunonica prostituta dell’Appia Antica, che poi campeggerà sulla locandina del film).
Si giunge, poi, a un altro decisivo capitolo, quello del ‘sottosuolo’, in cui vengono seguite le operazioni di trivellazione per la costruzione della metropolitana, opera urbana della durata infinita e che vide la luce solo nel 1980. Qui Fellini si addentra nelle viscere della città giungendo fino al suo cuore magmatico: un segnalatore rivela la presenza di un vuoto che fa presagire l’esistenza di un qualche resto della Roma antica. La fresa buca il muro di terra dando accesso al fantasmatico mondo della civiltà romana, nella fattispecie una meravigliosa casa patrizia in cui furono realizzati straordinari dipinti (eseguiti per l’occasione dai fidati Geleng) e che l’aria, penetrata dopo centinaia di anni, drammaticamente distrugge. Dunque, il progresso trova una costitutiva resistenza in Roma, la cui cultura millenaria non sopporta operazioni profanatorie.
L’avanspettacolo: in questo blocco il regista riminese calca la mano, ma non un per un proprio capriccio, piuttosto per essere fedele allo spirito di un evento che attirava il popolo, quello verace, che andava nei vari teatrini per sbirciare le gambe delle ballerine, ma anche, con grande goliardia, per esternare gli istinti più bassi, quelli del ventre, magari insultando, fino all’eccesso, il malcapitato ‘artista’ che cercava di portare a casa la pagnotta. Da segnalare la bella performance di un giovanissimo Alvaro Vitali che si produce in un’imitazione di Fred Astaire con tanto di lancio di gatto morto dalla platea.
Ancora: le case di tolleranza. Qui Fellini è abilissimo nel restituire l’atmosfera fumosa, sgraziata e fanfarona dei bordelli che abbondavano nella città santa e che il più delle volte fornivano l’occasione ai più giovani di fare la prima esperienza amorosa. C’è la casa popolare, con un nutrito gruppo di militari schernito dalla tenutaria che ne stigmatizza l’esitazione, invitando ad accoppiarsi velocemente con le sdrucite lavoratrici che scalpitano, insultano, mostrando oscenamente i propri corpi. E c’è la maison di alto livello, in cui il giovane Federico trova una sensuale ragazza campana, con la voce roca e gli occhi da gatta, a cui chiede ingenuamente un appuntamento.
E poi il fantasmagorico, eccessivo, trasbordante capitolo della ‘moda ecclesiastica’: Fellini, grazie al prodigioso lavoro del costumista e scenografo Danilo Donati, realizza una sequenza memorabile, entrata di diritto nella storia del grande cinema. Una passerella semicircolare viene percorsa in lungo e largo, deliziando lo sguardo dello spettatore, frastornato dalla bellezza abbagliante e al tempo stesso grottesca degli abiti ecclesiastici che sfilano uno dopo l’altro, fino a un finale roboante in cui, con una musica (di Nino Rota, ovviamente) che si fa sempre più inquietante, viene eretto uno sfarzoso baldacchino su cui si staglia, tra stoffe tappezzate con lamine color oro sgargiante, un Papa dal volto arcigno e malevolo, al cui cospetto tutti i presenti si genuflettono.
Si chiude con un incursione a Trastevere, cuore pulsante per antonomasia della città eterna, ma che già all’inizio degli anni Settanta era divenuta una delle mete preferite degli artisti italiani e stranieri che vi trovavano la giusta atmosfera per sviluppare la propria creatività.
Una masnada di moto, infine, invade la città, presagendo una mutazione antropologica che inevitabilmente trasformerà anche l’impermeabile Roma in una sontuosa succursale dell’impero economico globale.
Fellini compone un ritratto istantaneo con rapide ma incisive pennellate: Roma è là, tra l’oro dei vestiti talari, l’oscurità dei vicoli, il tanfo dei liquami, l’eccesso di cibo, la volgarità del popolo e la rassegnazione di un’aristocrazia morente, nel traffico disumano, nella bellezza sconvolgente dei secoli passati. Un miscuglio di sensazioni che attraversa lo spettatore sconcertandolo, divertendolo e perturbandolo.

Luca Biscontini
About the author
Luca Biscontini
Nasce nel 1974, anno in cui nelle sale italiane giungevano film straordinari, quali Profumo di donna, C’eravamo tanto amati, Gruppo di famiglia un interno, Il portiere di notte, Chinatown e La conversazione. Ama i film di Fellini, Pasolini, Tarkovskji, Orson Welles, Carmelo Bene, Godard, Rossellini, ma non disdegna il cinema popolare, ruspante. Perché non gli piace immedesimarsi, preferisce essere libero di muoversi negli spazi, tra profondità e superfici. Da più di quindici anni si occupa di critica cinematografica. Da dieci è caporedattore della rivista indipendente Taxi Drivers, ma ha collaborato e collabora con diverse testate cartacee e on line. Ha pubblicato vari saggi e articoli. Attualmente lavora a un testo sul cinema di Carmelo Bene. Non ama i professori, i baroni, quelli che si mettono in cattedra. Il suo motto è: “Eccedere e non cedere”.




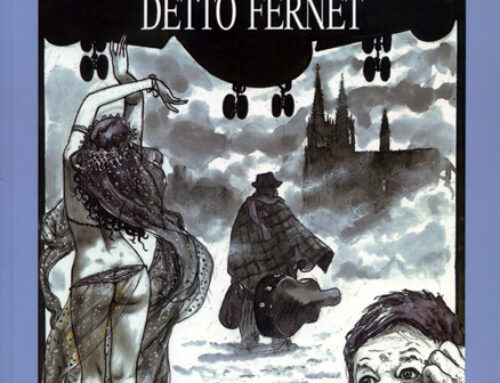


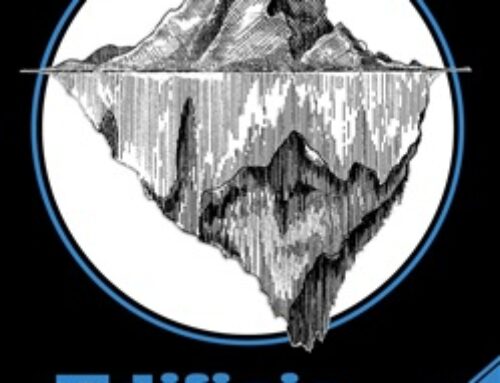
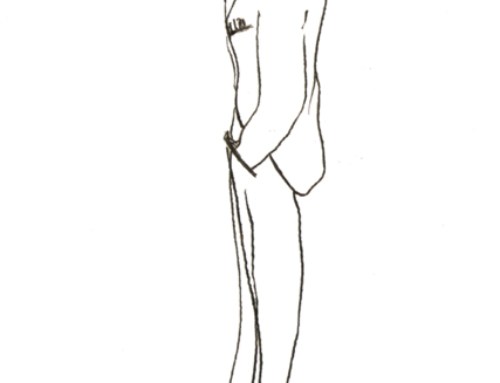
Scrivi un commento